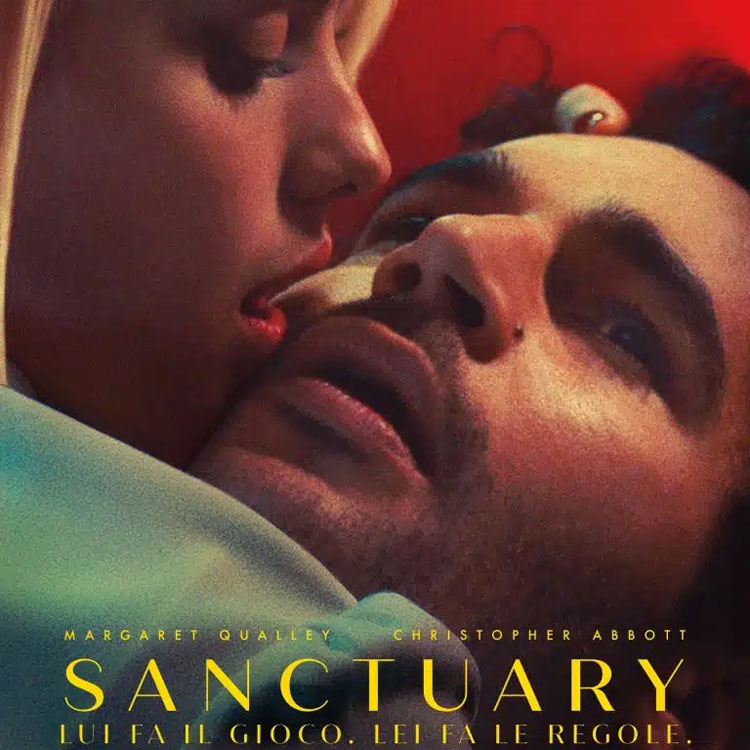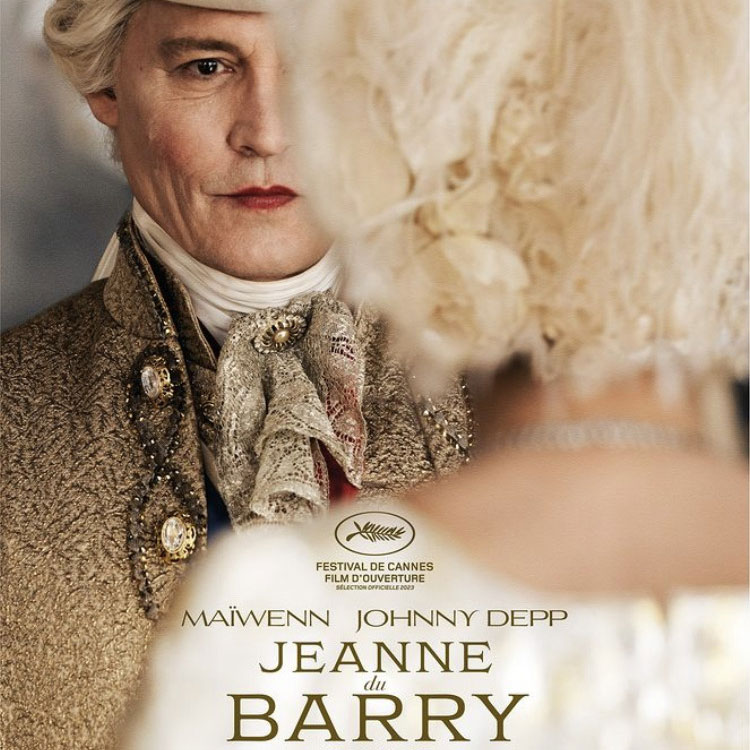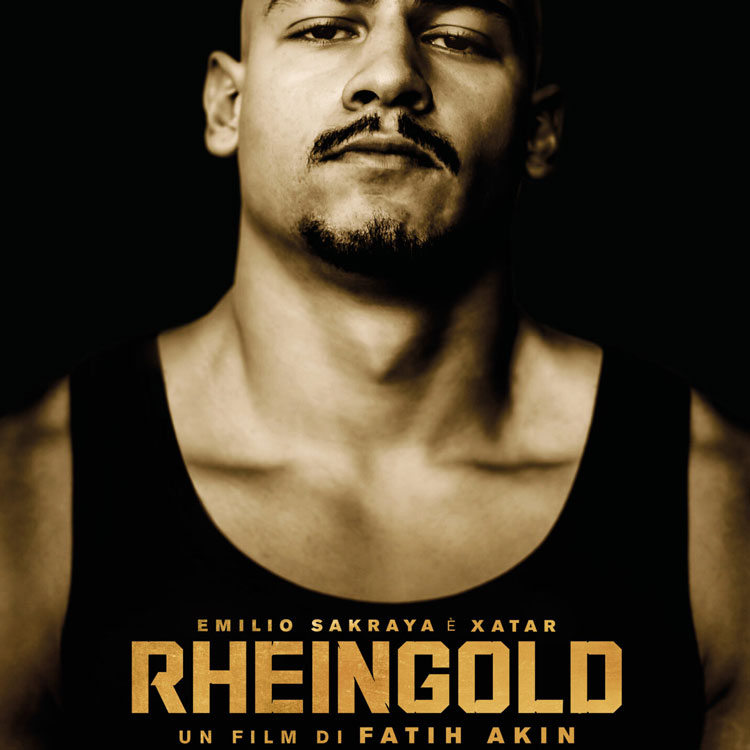EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE Daniel Kwan e Daniel Scheinert
 La storia è tanto banale che potrebbe essere sintetizzata in due righe senza fare spoiler: “Everything Everywhere All at Once” è il racconto di una famiglia che si perde e si ritrova nel segno della ritrovata comunicazione intergenerazionale e nel segno della gentilezza. Fine. Nel mezzo i The Daniels ci mettono un po’ di fantasy, un po’ di Matrix, tanto grottesco ed effetti speciali in quantità industriale. Sinceramente non è un film che resterà nella storia, ma negli ultimi anni quali film – premiati con gli Oscar più importanti – hanno l’ambizione di superare la stretta contemporaneità? Pochi, e “Everything Everywhere All at Once” probabilmente farà la fine di “Parasite” e altre robe simili perché stringi stringi non raccontano storie, ma provano a fare leva sulle sensazioni visive, un po’ come andare a una mostra di pittura ed essere ammaliati dalla musica in sottofondo – per carità, è parte integrante dell’allestimento, ma così si perde l’obiettivo dell’arte, e nella fattispecie del “fare cinema”, che essenzialmente dovrebbe essere il raccontare storie, grandi storie destinate a rimanere attaccate allo spettatore nel tempo. Ecco, negli ultimi anni questa capacità si è persa. Motivo per cui “Everything Everywhere All at Once” non ci è piaciuto e a parte alcune scene – vedi i due sassi che dialogano sul precipizio – ci è sembrato persino ridondante nel suo bisogno di rendere sempre tutto… amichevolmente grottesco. Il giochino dei The Daniels l’avevamo già visto in “Swiss Army Man – Un amico multiuso” e diciamo che questa volta è stato portato al massimo livello, ma stilisticamente quanto può durare nel tempo questo “esagerare tutto”?
La storia è tanto banale che potrebbe essere sintetizzata in due righe senza fare spoiler: “Everything Everywhere All at Once” è il racconto di una famiglia che si perde e si ritrova nel segno della ritrovata comunicazione intergenerazionale e nel segno della gentilezza. Fine. Nel mezzo i The Daniels ci mettono un po’ di fantasy, un po’ di Matrix, tanto grottesco ed effetti speciali in quantità industriale. Sinceramente non è un film che resterà nella storia, ma negli ultimi anni quali film – premiati con gli Oscar più importanti – hanno l’ambizione di superare la stretta contemporaneità? Pochi, e “Everything Everywhere All at Once” probabilmente farà la fine di “Parasite” e altre robe simili perché stringi stringi non raccontano storie, ma provano a fare leva sulle sensazioni visive, un po’ come andare a una mostra di pittura ed essere ammaliati dalla musica in sottofondo – per carità, è parte integrante dell’allestimento, ma così si perde l’obiettivo dell’arte, e nella fattispecie del “fare cinema”, che essenzialmente dovrebbe essere il raccontare storie, grandi storie destinate a rimanere attaccate allo spettatore nel tempo. Ecco, negli ultimi anni questa capacità si è persa. Motivo per cui “Everything Everywhere All at Once” non ci è piaciuto e a parte alcune scene – vedi i due sassi che dialogano sul precipizio – ci è sembrato persino ridondante nel suo bisogno di rendere sempre tutto… amichevolmente grottesco. Il giochino dei The Daniels l’avevamo già visto in “Swiss Army Man – Un amico multiuso” e diciamo che questa volta è stato portato al massimo livello, ma stilisticamente quanto può durare nel tempo questo “esagerare tutto”?
Altra cosa: “Everything Everywhere All at Once” è stato definito un film sul multiverso. Ci è sembrato più un miscuglio di generi tra “Matrix” e “Inception” o – per restare alle cose più recenti – l’ottimo e sottovalutato “Don’t Worry Darling”, ma nulla da legittimare Oscar a profusione e critiche d’oro. Diciamo – a voler essere cattivi, e a noi piace essere cattivi – che ultimamente c’è voglia di sapori… orientali, e questo sta portando a valanghe di premi ad artisti e opere che in qualche modo attingono a quell’area geografica. Motivi economici? Motivi di ispirazione? Altre logiche e dinamiche? Chissà, sicuramente noi nella nostra critica lamentiamo l’assenza delle storie, che poi alla fine dei giochi muovono sempre lo spettatore verso la sala.
La trama. Evelyn Quan Wang è un’immigrata cinese trapiantata negli Stati Uniti d’America che gestisce una lavanderia a gettoni insieme al marito Waymond. La tensione familiare è alta: la lavanderia a gettoni è tenuta sotto controllo dall’Agenzia delle Entrate, Waymond sta cercando di presentare a Evelyn le carte di divorzio, l’esigente padre di Evelyn, Gong Gong, è appena arrivato da Hong Kong e la figlia di Evelyn, Joy, cerca di convincere la madre ad accettare la sua ragazza Becky.
Cast con un ottimo Ke Huy Quan (meritato l’Oscar) e poco altro: Michelle Yeoh (la signora Todt) si è presa la statuina senza grossi sussulti da parte del pubblico nelle sale, mentre la statuetta a Jamie Lee Curtis vogliamo interpretarla come un omaggio alla carriera, perché in “Everything Everywhere All at Once” è giusto una macchietta, nulla più.
Bellissimi gli effetti speciali? No. Coraggioso invece il montaggio con varie chicche disseminate qua e là. Il finale è banale e pretenzioso, con acuti che vanno in direzione dell’esistenzialismo e dell’irrisolvibile rapporto genitori/figli. Insomma, un film che visto una volta non invoglia certo a rivederlo. Tra qualche anno se ne perderanno le tracce.